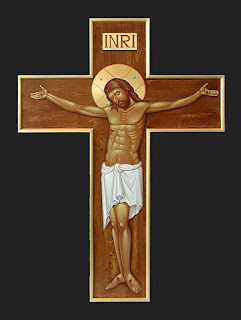Comunione e Solitudine
COMUNIONE E SOLITUDINE
NELLA TEOLOGIA GRECO-ORTODOSSA CONTEMPORANEA
La tematica di questo colloquio su
“comunione e solitudine” richiama alla mente di ciascuno la storia
dell’avventura dell’umano, di ogni realtà umana singola o comune, di ogni espressione
dell’umano; in modo paradigmatico quella dell’uomo con se stesso e i suoi
simili, con Dio e il mondo. Ma per chi si radichi nella storia biblica raccontata
dagli apostoli, tale tematica mi sembra rinviare innanzitutto al mistero pasquale
di Cristo e di ogni realtà e situazione umana in Cristo vissuta nella
profondità pneumatica del suo corpo misterico (ecclesiale) situato nel contesto
globale dell’economia paterna per noi.
Rispondendo
all’invito della Comunità di Bose per il quale mi sento profondamente
riconoscente e nella speranza di non deludere troppo le vostre aspettative, cercherò
di esporre brevemente alcuni punti significativi della riscoperta della
tematica sulla comunione fatta dalla teologia greco-ortodossa (dagli anni sessanta-settanta)
tramite i suoi maggiori esponenti, quali Christos Yannaras e Ioannis Zizioulas
(attuale metropolita di Pergamo), in
primis, ma anche Panayotis Nellas e altri. È da notare che in questi autori
la problematica della comunione è stata abbordata dal punto di vista teologico –
sistematico, in chiave ecclesiologica e prosopologica e dal punto di vista
storico-ermeneutico in un contesto epocale neo-patristico.
Parlare di una determinata
problematica (“comunionale” nel nostro caso) e della sua “riscoperta” o “rinascita”
in un determinato contesto epocale (neo-patristico in ultima analisi) significa
da una parte reperire le sue origini intellettuali nella storia del pensiero,
quella più vicina a noi prima, e dall’altra contestualizzare la sua riscoperta
in una situazione storico-teologica precisa; riconoscere cioè in questa
riscoperta sia i debiti (storici) ma anche i limiti (contestuali), senza per
niente minimizzare con ciò l’importanza storica della riscoperta, la grandezza
spirituale dei suoi autori e la fecondità straordinaria delle loro opere.
Ora in ciò che segue non intendo
tanto riferirmi a delle tesi concrete prosopologiche ed ecclesiologiche dell’uno
o dell’altro, quanto piuttosto alle strutture di pensiero sottostanti alle loro
tesi (determinando i contenuti), strutture che in fondo mi sembrano comuni. Non
vorrei qui esporre i vari approcci della problematica prosopologica ed
ecclesiologica sulla comunione dei pionieri di questa riscoperta. Tale cosa sarebbe
impossibile, visti i limiti del tempo e caricaturale data la ricchezza e la complessità
delle opere e delle sintesi dell’uno e dell’altro. Mi propongo invece, prima, di
contestualizzare la riscoperta accennando alla situazione storico-teologica di
allora (e quindi ai suoi limiti epocali). In seguito, mi soffermerò sugli
antecedenti storici della problematica ecclesiologica e prosopologica della
comunione, sul significato spirituale della sua rinascita in Grecia come pure su
alcune tra le questioni aperte che una certa struttura ermeneutica,
probabilmente ereditata e perpetuata forse inconsciamente in Grecia. Ciò facendo
allargherò in un certo senso lo status
quaestionis sulla comunione nella teologia ortodossa contemporanea.
Situazione storico-teologica
Sembra difficilmente negabile il
fatto che la teologia ortodossa del xx
secolo nel suo insieme, oltre che dalla presenza profetica della diaspora russa
in Europa occidentale e dal coinvolgimento panortososso al Movimento ecumenico è
stata profondamente segnata anche dal 1° Convegno Internazionale di Teologia
tenuto ad Atene nel 1936. Tra le varie voci presenti in questa circostanza, determinante
per noi è quella di Georgij Florovskij con la sua duplice tesi storica ed ermeneutica:
la tesi sulla “pseudomorfosi” della teologia ortodossa postbizantina, ossia sulla
sua occidentalizzazione (parte storica), come pure sull’ “ellenismo cristiano”
come categoria eterna della teologia (parte ermeneutica). Da qui in poi, Florovskij
si fece pioniere dell’urgenza quasi apocalittica per un ripristino immediato dell’ethos
patristico in teologia, attraverso una sintesi “neo-patristica”. In ciò fu
seguito quasi dappertutto, sovente in maniera semplificatrice e poco consona
alle sue intenzioni profonde. Ed è ben
nota l’ideologizzazione di un “ellenismo eterno dei Padri”. Benché queste cose siano
ben conosciute da tutti, mi permetterò di soffermarmi brevemente per richiamare
all’attenzione alcuni aspetti della tesi florovskiana; non tanto per se stessa
ma in quanto determinante la situazione storico-teologica della riscoperta in
Grecia della problematica prosopologica ed ecclesiologica sulla comunione
(dagli anni sessanta-settanta e forse fino ad oggi).
Nel centro della tesi
storico-ermeneutica florovskiana vi si trova, pare, una duplice aporia della
stessa fattura: l’aporia sull’identità ortodossa in piena modernità (in diaspora),
insieme a quella sul senso della tradizione ecclesiale nell’oggi della teologia
ortodossa. Per essere compresa e situata, la duplice tesi di Florovskij, benché
irriducibile alla genealogia, non potrebbe esserne certo dissociata. Mi
riferisco qui alla famosa “scuola di Parigi” di quegli anni che chiamerei per
convenzione “neo-ortodossa”: all’ambiente teologico-spirituale della diaspora
russa in occidente (di Bulgakov in primis,
ma anche di Florenskij e di Berdiajev per non citare che i più illustri). La
diagnosi di una “pseudomorfosi teologica” (cattività occidentale della teologia
ortodossa), la teorizzazione di un “ellenismo eterno dei Padri” e l’appello ad
una “sintesi neo-patristica” urgente rappresentano in un certo senso la replica,
o meglio la controproposta critica di Florovskij alla scuola “neo-ortodossa” di
Parigi riguardo alla questione sull’ autocoscienza dell’Ortodossia in piena modernità
e sul suo obiettivo e metodo teologico e spirituale. Pare insomma che il
progetto “neo-patristico” florovskiano, focalizzato su una forma pre-moderna di
pensiero (l’ellenismo cristiano che delimiterà in seguito i migliori tra i
nostri in Grecia) sia stato fortemente condizionato (e quindi delimitato) in
senso dialettico dal progetto “neo-ortodosso” della scuola di Parigi dell’epoca,
focalizzato esso sul post-medievale della modernità occidentale.
Ora l’appello ad un ritorno sull’ellenismo
diacronico dei Padri, anche se prospettato nel futuro (“avanti con i Padri”
diceva Florovskij) – o forse proprio a causa di questa specie di futurismo (aionismos) – in quanto progetto
“neo-patristico”, resterà essenzialmente un progetto “neo-bizantino” per cosi
dire, premoderno più che postmedievale (moderno). Da qui forse viene il suo
rapporto ambiguo per lo meno con la modernità cattolica, protestante e secolare;
con il nostro oggi culturale e la storia reale in breve e nonostante le sue
intenzioni.
Ma ciò non è mi sembra il più significativo.
Essendo finalmente “neo-patristico” (centrato sulla storia della teologia e
della spiritualità) e non prima di tutto “neo-apostolico” per cosi dire
(centrato sulla storia della salvezza stessa), tale progetto di rinnovamento
rischierà di favorire un inversione del rapporto tra storia della salvezza
(economia trinitaria) e storia delle teologie (storia delle chiese e tradizioni);
inversione del rapporto tra gli eventi salvifici stessi (secondo la
testimonianza apostolica - Bibbia nella celebrazione misterica) e i commenti
soteriologico-esistenziali più o meno autorevoli su questi stessi eventi
salvifici (tradizione e teologie). Se poi tal progetto di ressourcement teologico
viene assolutizzato, rischierà di restare non solo bloccato su alcune parti della storia della teologia
e della spiritualità nel suo insieme multiplo ma svolgersi senza rapporto organico con la stessa storia della salvezza,
l’economia trinitaria in Cristo, secondo la testimonianza biblico-apostolica, unica in maniera paradigmatica e fondatrice di ogni tradizione ecclesiale
susseguente. La tradizione rischierà di inghiottire l’unicità esemplare e
fondante del kerygma (testimonianza apostolica) ignorandola (facta dogmatica -
dicta probantia). Ora il passaggio da una tale visione di tradizione ai
tradizionalismi è spesso impercettibile, lo sappiamo tutti.
Riassumendo: nel suo intento di
impedire sia la dissoluzione della chiesa nel mondo che l’alienazione della
teologia dalla cultura – della teologia ortodossa dalla cultura occidentale
direbbe Florovskij – e la questione di un’articolazione ermeneutica corretta tra
l’Evangelion del Regno e le [nelle] culture della storia non essendo sufficientemente
problematizzata, il progetto florovskiano tornerà quasi fatalmente contro se
stesso provocando un corto circuito. Quando si tenta di esorcizzare un
occidentalismo teologico-culturale – in
solidum, è da notare – con un ripristino neo-patristico di simile fattura,
neo-bizantina per l’appunto, tale bloccaggio tra teologia e cultura (nella
storia del mondo) rischia di identificare in maniera idealista, atemporale, la tradizione
ecclesiale con la stessa storia della
salvezza (economia trinitaria), la tradizione – multipla e unica – poi con una
parte della storia culturale del mondo nella chiesa per salvare quest’ultima da
un’altra parte della sua storia (culturale) e della sua “altra” tradizione;
quella dell’occidente, che bene o male è la nostra di oggi quasi dappertutto.
È forse in tale contesto di ritorno
ad un “ellenismo cristiano” paradigmatico, e alle sue strutture concettuali
supposte eterne – più che agli stessi fatti della “storia della salvezza” (o
“economia trinitaria”) a partire del suo evento centrale ed unico (eph’hapax), la Pasqua di Cristo – che la
riscoperta della problematica sulla comunione personale, nella libertà come
amore, si effettuerà nella teologia greca. Fino ad oggi forse, la riscoperta
della tematica comunionale in chiave prosopologica ed ecclesiologica sembra imprigionata
in una situazione storico-teologica di tipo neo-medievale; e ciò nonostante l’immenso
sforzo di I. Zizioulas, per non citare che un solo nome, di inquadrare l’“ellenismo
cristiano” patristico in una prospettiva biblico - apostolica,
“storico-salvifica”. Detto questo non intendo minimamente mettere in
discussione la grandezza sistematica e l’importanza spirituale delle sintesi comunionali
degli illustri pionieri greci. Mettere in risalto una situazione epocale (e i
suoi limiti) ci incita anzi a riprendere delle riletture rinnovate delle opere,
le loro, straordinariamente ricche in intuizioni teologiche e spirituali; e per
noi comunque preziose.
Antecedenti storici e limiti della riscoperta
Nessuno o quasi negava in Grecia, a
partire dagli anni sessanta-settanta perlomeno, il bisogno di un autentico rinnovamento
teologico nella fedeltà alla tradizione ecclesiale e al servizio dell’uomo
contemporaneo. Secondo il paradigma “neo-patristico” (dell’ellenismo cristiano)
tale rinnovamento era però inteso grosso modo come traduzione attualizzante o
meglio come trasposizione al presente storico-culturale delle intuizioni dell’ellenismo
patristico: un rinnovamento come cambiamento a livello di linguaggio in
teologia (esistenziale), a livello di presupposti
e di contenuti (neo-patristici). In un breve periodo, il linguaggio
esistenziale soppianterà in breve tempo quello scolastico di Trembelas, di
Karmiris (e molto prima di loro di Andrutsos) nelle opere di Yannaras e di
Zizioulas, per non citare che questi due pionieri illustri. Si potrebbe forse
dire, schematizzando certo, che ad un accademismo scolare centrato su una metafisica astratta delle essenze, succede
allora un approccio esistenziale e mistico centrato sulla persona concreta e l’evento di comunione, sul mistero profondo della
chiesa, sulla sua testimonianza nel mondo e la sua presenza nel cuore del’uomo
contemporaneo. [Dal fisiocentrismo al prosopocentrismo: ma basterebbe solo
questo per un autentico rinnovamento in Cristo della teologia?]
Come è stato osservato con
pertinenza, l’ecclesiologia è stata la tematica dominante della teologia
ortodossa del xx secolo. Ora la
questione sulla natura profonda della chiesa e il tipo della sua unità organica
– in base alla comunione nella libertà e nell’amore reciproco – era già stata
sollevata, in Russia a metà del xix
secolo, dagli slavofili (A. S. Chomjakov in particolare). Sotto l’influsso
profondo del romanticismo tedesco (cf. J.-A. Mohler e la scuola cattolica di
Tubinga) la chiesa era allora pensata come un vivo miracolo di unanimità, nella
libertà e nell’amore mutuo, a immagine della perichoresi delle persone della
Trinità ove esiste eternamente, in prospettiva slavofila, una riconciliazione
autentica tra libertà e unità, archetipo dell’unità organica di tipo
comunionale della chiesa.
Mi permetto di attirare qui la
vostra attenzione sulla struttura iconologica nel ragionamento idealista russo e
di notare per inciso, anticipando sul seguito, la corrispondenza di tipo speculare (iconologia in chiave idealista)
tra chiesa e SS. Trinità (immagine ed archetipo), tra comunione ecclesiale e
comunione trinitaria. Una tale corrispondenza di tipo speculare si ritroverà malgrado
tutto a livello ecclesiologico per esempio in Zizioulas (probabilmente via i
residui slavofili di Afanass’ev, come contesto comunionale della struttura
ecclesiale) come pure a livello prosopologico per esempio in Yannaras (in
seguito forse a Berdiaev e come contesto comunionale della personeità umana).
La realtà ecclesiale nel suo profondo (escatologico) e quella umana nella sua
verità (eucaristica) saranno pensate come intrinsecamente relazionali e
comunionali a immagine della realtà trinitaria (increata). Su questa struttura speculare, essenzialmente binaria della
realtà – ove la mediazione di Cristo tra increato e creato non è strutturante
(superflua?) – e sull’importanza della questione iconologica in teologia cristiana ritornerò in seguito.
Sarebbe completamente sbagliato e
fuorviante passare direttamente dall’idea
di comunione secondo l’ecclesiologia idealista degli slavofili russi del xix secolo alla riscoperta della comunione
ecclesiologica e prosopologica nei Pionieri greci degli anni sessanta-settanta
(esistenzialismo cristiano). Questo vale in
primis per Zizioulas ma anche per Yannaras, per non citare che due tra i
più noti. Ciò nonostante, come è stato recentemente osservato, “non è
accidentale che il riconoscimento positivo di gran parte dei contributi
slavofili, alla fine del xx secolo,
avviene con una nuova onda di reazione estesa alla cultura dell’illuminismo,
alla sua scienza, individualismo e teologia”.
L’importanza del pensiero russo
ortodosso della diaspora per la generazione teologica degli anni sessanta in
Grecia non potrebbe essere abbastanza sottolineata. La problematica slavofila sulla
comunione, accompagnata da una struttura speculare
di iconologia filosofica (idealista) –
ed è ciò che mi sembra importante – arriva e si impone da noi, nella sua duplice
forma ecclesiologica e prosopologica. Da parte ecclesiologica, arriva mediata tramite
la rilettura di Afanas’ev (in Zizioulas); da parte prosopologica, è mediata
tramite quella di Berdiaev (in Yannaras – attraverso una rilettura della prosopologia
triadologica di Lossky, prolungata in maniera creatrice (o meglio proiettata in
maniera anti-losskiana) in antropologia, con il contributo decisivo per il
nostro dell’ontologia heideggeriana via Sartre).
Non si può negare, credo l’influsso
dell’ “eucaristiologia ecclesiologica” (e pneumatocentrica) di Afanas’ev su
Zizioulas. L’ultimo, si sa bene, effettua una doppia correzione in
ecclesiologia; da una parte tenta di equilibrare il pneumatocentrismo di
Afanasiev dialetizandolo con il cristocentrismo di Florovskij in una specie di
cristo-pneumatocentrismo ecclesiologico e d’altra parte tenta di sintetizzare
l’eucaristiocentrismo carismatico di Afanas’ev con un episcopocentrismo istituzionale:
la sua ecclesiologia comunionale essendo cristo-pneumatica non potrebbe essere
chiamata semplicemente eucaristica, ma mi sembra eucaristica-e-conciliare. Malgrado
tutte le correzioni dialettiche equilibranti in ecclesiologia (cristologia-pneumatologia,
istituzione-carisma, storia-escatologia) e nonostante i suoi lavori
interessanti sull’iconologia la struttura ermeneutica binaria, speculare della realtà, dell’icona e dell’iconismo, alle
origini filosofiche (idealiste) della quale abbiamo sopra accennato, resta
sempre presente nella sua sintesi condizionandola; o meglio
contestualizzandola... Ed è qui, a mio modesto parere, tutta l’importanza di un
approfondimento rinnovato della questione su un’iconologia (veramente teo-logica) -e correlativamente su una misteriologia (veramente trinitaria)- in
chiave decisamente cristica, vale a
dire storico-salvifica.
Articolazioni iconologiche e questioni aperte
Per capire questa mia affermazione
sull’importanza delle strutture ermeneutiche e della questione iconologica in
regime cristiano mi permetterò di formulare qui alcune delle mie aporie
prosopologiche ed ecclesiologiche, sull’idea di comunione e di partecipazione alla
comunione. Prima di passare all’ecclesiologia eucaristica comincio con la
prosopologia relazionale. Quest’ultima sembra quasi più urgente come questione.
Sottoscrivo in pieno all’ipotesi di monsignor Kallistos Ware secondo il quale
in ambito teologico, il nostro nuovo millennio sarà quello dell’antropologia,
senza che per questo venga meno l’interesse per l’ecclesiologia. Come lo dice
bene l’illustre autore la questione centrale non sarà più soltanto ‘cosa
significa essere chiesa’ (per le nostre comunità) ma anche – e più
profondamente – ‘cosa significa essere persona’ (per l’uomo come tale) segnalando
comunque la connessione intima per noi cristiani delle due questioni.
Ora la mia aporia prosopolgica è la
seguente: l’uomo-creatura di Dio è stato creato finalmente – in senso ontologico ed escatologico – a immagine della Trinità oppure a
immagine di Cristo? Tale aporia, che non è solo mia, non mi sembrerebbe
triviale o scolare bensì profondamente soteriologica. Poiché nel primo caso, se
non sbaglio, la struttura del dono di personeità
(nell’uomo) sarebbe “triadologica” (ossia relazionale, comunionale, eccetera);
mentre nel secondo caso sarebbe strettamente cristica, per l’appunto
cristo-misterica in senso trinitario (filiale
per grazia, davanti al Padre e in attesa della cristificazione escatologica). In
quale direzione va effettivamente la testimonianza apostolica è da tutti
conosciuto. A ragione P. Nellas osservava che l’uomo non può essere detto semplicemente
immagine di Dio ma immagine dell’immagine
(unica) di Dio, perfettamente somigliante (increata) a Lui (il Padre) per
natura, incarnata per noi (per grazia) come suo dono personale: come dono paterno stricto sensu, trinitariamente dispensato (cf. il Padre trinitario). Secondo quest’ultimo
approccio (biblico-cristico) abbiamo un altro tipo di iconologia, non
filosofica né di struttura binaria (immagine-prototipo) ma storico-salvifica; e
per cosi dire ternaria, anzi misterico-trinitaria (cf. il mistero di Cristo,
punto focale e ricapitolazione dell’economia paterna). L’uomo non è immagine di Dio se non in Cristo
ed attraverso Lui (nello Spirito). E dunque Dio, in tale contesto, significa
Padre.
Venendo adesso all’aporia
ecclesiologica mi domando: la chiesa comunionale (eucaristica ecc) costituisce finalmente –nel doppio senso ontologico
ed escatologico del termine – l’immagine della Trinità oppure quella del Regno
escatologico? (Notate che nell’opera di Zizioulas, per esempio, è sostenuta sia
l’una che l’altra iconicità e noi cerchiamo di capire la struttura iconologica…).
Di nuovo, nel primo caso la struttura del dono
sacramentale di ecclesialità (nella
chiesa) sarebbe “triadologico” (relazionale, comunionale, eccetera), mentre nel
secondo caso sarebbe cristo-misterico in senso trinitario; ossia materno per grazia, davanti al Padre, in attesa
della ricapitolazione escatologica in Cristo e nello Spirito.
Non vorrei stancarvi di più con
queste mie aporie soteriologiche. Modestamente ritengo che in prospettiva storico-salvifica
(di economia trinitaria) la chiesa non può che essere in via essendo innanzitutto
cristo-misterica; seguendo cioè Cristo nella sua Pasqua verso il Padre, il
Regno escatologico ed eterno. E che in quanto comunionale ed eucaristica, la
chiesa comunionale ed eucaristica non potrebbe essere detta in campo teologico
come semplicemente immagine della comunione trinitaria, bensì come immagine dell’immagine (escatologica)
della comunione trinitaria, nel (del?) Regno venturo di Dio.
Tutto ciò
suppone ovviamente che la storia della teologia (cf. tradizione ecclesiale) non
si confonda, non soppianti ma sottostà alla storia della salvezza (cf. economia
paterna); e sopratutto che non si perda il senso (orientamento, prospettiva)
del “fondamento” (storico-salvifico) in teologia (ecclesiale) invertendo
l’ordine del chi fonda che cosa e chi interpreta che cosa …
Parlando di “economia trinitaria” o
“dispensazione paterna” in modo trinitario – da non confondere con il modo
“triadologico”, di una coesistenza panoramica, parallela – faccio qui
riferimento all’economia della rivelazione del Padre in Cristo e nello Spirito,
alla storia della salvezza, quella dell’autodonarsi di questo Dio a noi
nell’umanità di Cristo per mezzo dello Spirito; quella dell’autodonarsi del
Padre in Cristo e per mezzo dell’umanità cristica
e sacramentale (ecclesiale)
dell’autodonarsi di Dio all’intera Sua creazione, al nostro mondo. Le categorie
soteriologiche dunque di “rivelazione” e di “economia” vanno intese in modo trinitario (non
“panoramico-triadologico”) e si riferiscono rispettivamente al mistero della presenza e dell’azione salvifica di Dio (il Padre, in Cristo e nello Spirito) a noi
nella storia per la vita del mondo. Per la fede biblica – nella sua rilettura apostolica
per lo meno – l’economia di Dio per noi (in Cristo) e l’“economia della
rivelazione” di questo Dio (nella storia) si implicano a vicenda; esse sono finalmente lo stesso mistero (cf. Ef. 1,
3-14).
Storia delle teologie e delle culture – storia
della salvezza
(economia e rivelazione)
In regime biblico-ecclesiale e per
la fede apostolica si tratta di “economia trinitaria” e di “rivelazione
trinitaria”, dell’agire e dell’autodonarsi trinitario di Dio e Padre (in Cristo
e nello Spirito) a noi e per tutti;
per l’intera umanità travagliata dall’inizio e per l’insieme della creazione,
abusata in modo persistente. Se dunque i termini comunione e solitudine
richiamano la storia dell’avventura umana (in Adamo nella solitudine della
separazione: delle tradizioni teologiche e delle chiese…), per noi cristiani
richiamano prima di tutto la storia dell’economia-e-rivelazione trinitaria di
Dio e Padre (in Cristo e nello Spirito: la salvezza in Cristo delle tradizioni
teologiche e delle chiese…). E quindi, a partire del mistero pasquale di Cristo
Gesù (nello Spirito e verso il Padre) ci spingono a meditare sul mistero
personale-in modo ecclesiale di Gesù di Nazareth (nella storia e verso il regno
venturo), verso il compimento escatologico dell’economia-e-rivelazione del
nostro Dio.
Conclusione
Cari amici: quando la storia (della
chiesa) e l’ermeneutica (della tradizione) in teologia, quando la storia delle
teologie (cf. tradizione delle chiese) e la storia della salvezza (cf. mistero
di Cristo) non mantengono continuamente le loro alterità reciproche l’una verso
l’altra, tale un dialogo aperto al futuro
di Dio, ossia all’avvenire del Regno –
inteso quest’ultimo come un terzo,
come giudice definitivo – allora in teologia cristiana l’ermeneutica
(storico-salvifica) rischia di essere bloccata dalla e nella storia (delle
teologie); ciò tramite un corto circuito ermeneutico che rischia di confondere
lo storico-teologico plurale (peggio, una parte dello storico-teologico) con lo
storico-salvifico in Cristo (nella sua cattolicità escatologica).
La costatazione storica di una
“pseudomorfosi” non-ortodossa in piena ortodossia, al dire di Florovskij, e il
suo plaidoyer ermeneutico per un’urgente
sintesi “neo-patristica” sono strettamente collegati. A mio modesto parere la
questione sul cerchio ermeneutico tra storia, mistero e salvezza in teologia
cristiana, la questione di un’articolazione pertinente tra storia della
salvezza, storia della cultura e tradizione ecclesiale (nella storia e verso il
regno) non è stata finora sufficientemente problematizzata in campo ortodosso. L’articolazione
tra storia ed ermeneutica in teologia sistematica coram Deo, tra teologia e cultura nella chiesa davanti al Regno
venturo, resta sempre un punto delicato, direi il punto debole di ogni progetto
di tipo “neo-patristico”; in quanto appunto progetto tendente ad omogeneizzare
la storia delle teologie e, confondendola con la storia della salvezza, ad idealizzare
la tradizione patristica o una parte di essa (cf. l’ellenismo patristico come
“categoria eterna dell’esistenza cristiana”) erigendola a fondamento al posto
della testimonianza apostolica.
Dal punto di vista storico-salvifico
ed in contesto teologico la storia (e la tradizione ecclesiale nella storia)
non è omogeneizzabile, per il fatto che è costituita in modo paradossale sia
nella pluralità ecclesiale ma soprattutto come continuità nella discontinuità:
non solo in continuità con il passato ma anche nella discontinuità rispetto al
passato (in apertura alla novità del futuro di Dio). Ed è costituita nel “oggi
di grazia”, la storia, non a partire da
se stessa (come auto-possesso del suo passato nell’oggi) ma a partire dal regno
venturo, dal futuro sempre nuovo ed imprevedibile in assoluto di Dio-con-noi, come
suo dono. Da questo punto di vista escatologico (o meglio escato-misterico), un
tradizionalismo teologico come pure un modernismo teologico, avendo perso di
mira il fondamento (storico-salvifico), si accostano nella semplificazione del
paradosso (cioè del mistero) del dono ecclesiale (e della tradizione
ecclesiale) di Cristo nella storia. Il modernismo punta sulla discontinuità
culturale a scapito della continuità (finalmente dell’eph’hapax paolino) e il tradizionalismo in senso inverso tenta di
esorcizzare la discontinuità culturale sostituendola con una continuità
artefatta, idealizzata e proiettata nell’assoluto (o nel futuro) come categoria
eterna della teologia. Mi sembra pero che tutti e due, sebbene in modo opposto,
tentino di autoporsi, di autofondarsi nella storia – a partire della sola storia (modernismo) o della sola Traditio (tradizionalismo) – anziché
di riceversi sempre di nuovo nella storia à partire dal fondamento stesso della
storia: a partire dell’Altro della storia, a partire dal regno venturo di Dio e
come suo dono (del regno) per noi e la nostra storia.
PUBLICATO in S. Chialà, L. Cremaschi e.a
(a cura di), Comunione e Solitudine: Atti
del XVΙΙΙ Convegno ecumenico
internazionale di spiritualità ortodossa, Bose 8-11 settembre 2010,
edizioni Qiqajon, Magnano 2011, σ. 255-268.