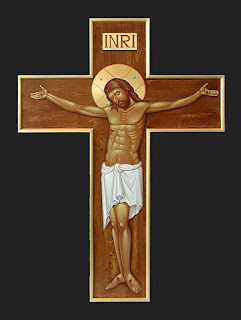Chiese e Matrimoni nella storia della Cristianità
Chiese e Matrimoni nella storia della Cristianità:
la “sacramentalità dell’amore” sub specie Regni
venturi.
Riflessioni sul “mistero sponsale in Cristo”,
nel “tempo dell’Avvento”, in “prospettiva ortodossa”[1]
Dr Konstantinos Agoras
Ringrazio innanzitutto
profondamente gli organizzatori di questo Colloquio dell’Istituto
ecumenico-patristico “S. Nicola” per l’invito fattomi a partecipare, dedicato
quest’anno alla problematica del matrimonio tra cattolici e ortodossi. Ragioni
indipendenti dalla mia volontà non mi hanno permesso di essere presente
“fisicamente” tra di voi, bensì solo “nello spirito” come direbbe l’Apostolo.
Tale invito fattomi qui, proprio accanto
alla presenza della memoria di S. Nicola, cari amici, cattolici e ortodossi, mi
onora particolarmente e mi tocca profondamemente. Per di più mi riempie di
speranza, di gratitudine e di gioia. Perchè e in che modo? Per l’Avvenire
dialogico ed ecclesiale – in Cristo Signore – delle nostre Chiese e
nelle nostre Chiese. Per l’“Avvento stesso” nella Chiesa e della Chiesa,
l’Una Sancta, la “Chiesa di Chiese” sposata paradossalmente dal e nel Signore,
già e non ancora, nell’Avento paradossale e misterico del Regno avvenire.
Permettetemi dunque di
partecipare all’approfondimento della tematica “sponsale-eucaristica” di questo
Colloquio dialogico-teologico, in un modo strano a dir poco, spaesante,
ispiratomi forse dalla mia presenza a S. Nicola, patrono del dialogo e forse
pure delle “nozze future” tra cattolici e ortodossi; e ciò proprio nel “Tempo
dell’Avvento nel Signore”. Non parlerò direttamente né di matrimoni in
genere e neppure di matrimoni misti tra cattolici e ortodossi; bensì
del “mistero dell’Avvento” - e del “mistero sponsale” nell’“essere ecclesiale”
- da un punto di vista “liturgico-teologico ortodosso”.
1 - Nella fede, nella speranza e nell’amore (αγάπη)
In questo contesto, l’invito non
potrebbe che riempirmi di speranza nel Salvatore nostro Gesù Cristo, “che è
venuto”. Di gioia, nel ”Signore” nostro che sta “per venire”. E di fiducia nel
Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, nel Cristo Gesù, l’unto di Dio (χριστός) e Messia di ogni Israele - e di ogni Chiesa,
cattolica, ortodossa, evangelica - “che verrà”; senz’altro e nonostante il
fatto che ignoriamo il quando, il dove e il modo suo. Sforziamoci di decifrarlo
restando sempre più aperti agli imprevisti che ci potranno sorprendere, o
addirittura sconvolgere.
Che verrà nelle Chiese che
formano ancora adesso, ciascuna a “modo suo” (o a “modo Suo”?), ciascuna dal
“suo punto di vista” (o dal “Suo punto di vista”?) una “Chiesa di Chiese”:
ugualmente, a mio modesto parere, sebbene in modo storicamente diverso.
Mi riferisco qui, cari amici, ai due modi di ecclesialità nelle “Chiese
sorelle”. Ed ecclesialità significa “mistero sponsale, mistero liturgico e
mistero eucaristico”. Ecclesialità, dal Cristo e in Cristo, dal Padre e al
Padre, nella comunione dello Spirito Santo e della comunione nello Spirito
Santo. Ecclesialità che sta nella sua comunione, prima di tutto e dopo tutto.
Ma anche, in modo sinergico, di co-operazione, di con-venire, nella nostra
partecipazione indivisibile e inconfusa a questa sua comunione unica e
indivisibile. La comunione dello Spirito, in Cristo verso il Padre.
Appunto come lo invochiamo, gli
uni e gli altri, in ogni celebrazione eucaristica: “La grazia del Nostro
Signore Gesù Cristo + L’amore di Dio (e) Padre + La comunione dello Spirito
Santo, sia con tutti noi. Amen.
Fatta umilmente questa
invocazione liturgico-eucaristica, mi sia permessa una chiarificazione
supplementare. Chiarificazione fondamentale per me riguardo all’uso dei termini
“cattolico” e “ortodosso”.
Dal punto di vista ecclesiale,
cioè dal punto di vista della “fede” in Cristo nell’Una Sancta, i
termini, si sa bene, sono strettamente coestensivi. Parlando a titolo teologico
personale (e spero anche ecclesiale), i termini “ortodosso” e “cattolico” sono
qui intesi in correlazione al termine “Chiesa” e quindi tra di loro. Vanno
dunque distinti in modo inseparabile e inconfuso in riferimento a due modi
diversi di cattolicità ecclesiale nella storia. Perlomeno come essa si presenta
di fatto nella nostra storia attuale[2]. Intendo dire la “cattolicità ortodossa” e la
“cattolicità romana”. Due modi diversi di cattolicità (divergenti o
convergenti?) dal punto di vista della storia che considera il “presente” a partire
dal “passato”.
Visto però che la “fede” (in Dio
Padre, per mezzo di Gesù Cristo e nello Spirito Santo) ha un senso decisamente
escatologico nella storia (in via), decisamente epicletico
più che meramente anamnetico, secondo la Lettera agli Ebrei se non altro (cap
11); visto anche che tale “fede” è inseparabile dalla “speranza” (nel Regno
avvenire) e soprattutto dalla “carità” stessa, reciproca, sulla base della
agape di Dio Padre, per di noi, in Cristo e nello Spirito. Perciò, in
coscienza, non vedo per quale motivo potremo essere giustificati, davanti a
Lui, nel nostro continuare ora a considerare il passato della nostra storia
sotto il punto di vista dello stesso suo passato anzichè dal punto di vista del
suo futuro “nella fede”: dal punto di vista del Regno avvenire e in prospettiva
escatologica, in una prospettiva escatologicamente inversata nello sguardo di
“fede”; Inversata in un modo iconologico di “rileggere” ora la storia in un modo
“profetico” (nella storia) e “non circolare” (della storia stessa),
ciclostilata per così dire. Intendo dire, nel modo del “Regno avvenire” (sub
specie Regni Dei adventis) e dal punto di vista del suo futuro (avvenire),
offerto qui ed ora a noi (da ricevere), nella “fede” alla sua Parusia: nella
fede nel nostro Signore che viene e che verrà senz’altro. Questo mi sembra
essere il vero senso liturgico dell’Avento nella storia liturgica delle Chiese,
la sua vera celebrazione in atto, tra noi e con loro.
Credo profondamente che questo
futuro – l’avvenire del Regno Parusiaco nella storia delle Chiese – sta proprio
nascosto nel “mistero stesso dell’Avvento” che gli uni e gli altri celebriamo
ora liturgicamente. E ciò perché alla “prima venuta” del Messia di Israele e
Signore della Chiesa, che sta per “ad-venire” (evento) nella sua gloria
messianica, parusiaca, apocalittica, seguirà senz’altro il suo secondo e
glorioso Avvento, propriamente Parusiaco. E, quindi, la nostra vera vita di
risurrezione nella gloria del Corpo suo. Tale perlomeno è atteso il Signore da
noi. Ed è qui che dobbiamo stare attenti, gli uni e gli altri e ciascuno con
tutti: attenti come “Chiesa vigilante”.
Attenti certamente a decifrare “i segni dei tempi” nel
mondo, ma attraverso la nostra inversione iconologica nello sguardo. Con
l’occhio fisso sulla storia, la nostra e del mondo, ma visti dal punto di vista
del futuro, non del presente, neppure del passato. Credo profondamente che
“essere Chiesa” – al plurale e spero al plurale comunionale – significa tra
l’altro “essere all’avanguardia del suo ultimo e glorioso avvento”, della sua
Parusia. Perché “Parusia” significa in greco “Presenza”: Preseza escatologica,
proletticamente anticipata da Lui – e sacramentalmente partecipata da noi,
ancora in parallelo purtroppo tra di noi – nell’“azione di grazie” (ευχαριστία), innanzitutto per le sue grazie (χάρις), “azione di grazie” in liturgia di ringraziamento (ευχαριστία), di gratitudine e di riconoscenza, la nostra verso
il Padre, in Cristo e nello Spirito, nello Spirito escatologico del Regno
avvenire.
2 - Una “prospettiva “ortodossa”?
Rivolgendomi ad un uditorio misto
non mi è possibile evitare una doppia affermazione preliminare, che vi sembrerà
paradossale, almeno all’inizio.
Non esiste “un’unica” teologia
ortodossa e ancora meno una teologia “ufficialmente” ortodossa. E ciò perché non
esiste “una sola” Chiesa “ortodossa”, bensì varie uniche Chiese “ortodosse” in
comunione di “ecclesialità liturgica” le une con le altre; comunione
ecclesiale sulla base della loro “comunione dossologica, escatologica e
eucaristica” (in Cristo risorto e nello Spirito escatologico) con
il Padre: con la fonte di “vita vera” (incorrutibile) e di ogni benedizione e
grazia (di rinnovamento), che discende sempre di “nuovo”, verticalmente verso
di noi, in ogni “hodie liturgico” nella Chiesa, proveniente dal futuro ultimo
della storia, dal Regno-avvenire, escatologico. Giusto per attirarci, per così
dire, verso questo futuro, il nostro avvenire: di ciascuno e di tutti; in
comunione ecclesiale misterica con il Padre nostro, in Cristo e nello Spirito.
Come Chiesa di Chiese.
Che cosa allora potrebbe o non
potrebbe significare una prospettiva “ortodossa”? Mi sia permesso qui di
riferirmi a uno tra i maggiori teologi ortodossi viventi, al metropolita I.
Zizioulas.
“Ogni volta che debbo trattare un
tema ‘dal punto di vista ortodosso’ –riconosceva l’autore negli anni ’80 – mi
trovo in grande difficoltà. Cos’è il ‘punto di vista ortodosso’? Come
determinarlo? Su quali basi e a partire da quali fonti? Gli Ortodossi non hanno
un Vaticano II a cui poter attingere. Non hanno una loro Confessione augustana
e mancano dell’equivalente di un Lutero o di un Calvino per attribuire loro una
precisa identità confessionale. Le sole fonti che possiedono in fatto di
autorità sono loro comuni con il resto dei cristiani: la Bibbia e i Padri. Come
si può, allora determinare una posizione che sia specificamente ortodossa
sulla base di ciò che è comune con i non Ortodossi?” si chiedeva il nostro,
ponendo con ciò la priorità dell’interrogazione sulla questione
dell’ermeneutica stessa in teologia (ortodossa per lo meno) piuttosto che sulle
posizioni o affermazioni teologiche degli uni e degli altri.
La risposta che si dava Zizioulas
è che lo specifico “ortodosso” sta nei diversi presupposti
ecclesio-misteriologici, degli uni e degli altri, sottostanti alle
interpretazioni della “grande tradizione ecclesiale” (apostolica e liturgica,
patristica e conciliare): di quella che chiamiamo teologicamente (e non in modo
meramente storico) “la Tradizione” (come pure i “Padri”) della
“catholica”, in Oriente come in Occidente. Ed è per questa ragione che poco fa
mi sono riferito alla nostra esperienza liturgico-misterica della
partecipazione “prolettica” e “paradossale” al “corpo di Cristo” (in senso
ecclesiale-e-eucaristico) riferendomi al mistero per eccellenza, al
“mistero dei misteri” (cfr. “i divini misteri”), alla liturgia eucaristica
della Chiesa (di Chiese) come “Sacramentum futuri”.
La celebrazione eucaristia, o
meglio la Divina Liturgia - delle nozze dell’Agnello, della glorificazione
trina di Dio trinitario, e della festa del banchetto nuziale nella casa del
Padre - è qui intesa globalmente come liturgia di ringraziamento, di
gratitudine, in rendimento eucaristico di grazie. Ed è la liturgia misterica
stessa che è vissuta in eucaristia e come eucaristia, come il mistero
sacramentale per eccellenza della Chiesa come Chiesa ad extra (al
Regno avvenire) - rivolta al Padre (nel Regno avvenire) per la pienezza dei
suoi doni in Cristo; già ricevuti in anticipo o da ricevere nel futuro; doni
ricevuti o da ricevere, poco importa (nella fede, nella speranza e nella
carità); doni ricevuti o da ricevere dalla pienezza della comunione dello
Spirito Santo (in senso verticale, ontologico) e nella pienezza della comunione
dello Spirito Santo (in senso orizzontale, escatologico). Questo contesto
soteriologico mi sembra essere un punto di partenza possibile per un
approfondimento sulla tematica del colloquio.
L’“azione di grazie” (ευχαριστία) – cattolica e cosmica, escatologica e comunionale,
sacramentale e profetica, cosmica e apocalittica – costituisce il fulcro, il
contesto, il “Sitz im Leben” della sacramentalità stessa della Chiesa (sacramentum
futuri) in tutti i suoi aspetti particolari nella vita umana e cosmica. È
questa la ragione - liturgico-eucaristica e escato-sacramentale - nella Chiesa
e della Chiesa che sottostà alla visione ortodossa del matrimonio. E che crea
delle difficoltà ecclesiologiche, misteriologiche, ecumeniche e pastorali e chi
sa che cos’altro ancora.
3 – Comunione sponsale “ecclesio-eucaristica”
in una “Chiesa di Chiese”
La comunione ecclesiale di ognuna
delle Chiese con le altre (in Cristo e nello Spirito verso il Padre)
passa prima di tutto dal Padre stesso nel suo Regno escatologico ove ci aspetta
tutti, se posso dire, nella sua dimora (“ascensione” ecclesiale nello Spirito,
in Cristo, verso il Padre). Di là poi tale comunione ecclesiale,
escatologicamente rinnovata, discende verso di noi nella storia del nostro
mondo come dono paterno “di bontà e di perfezione” (discesa ecclesiale
nello Spirito, in Cristo e verso la storia).
Vadano qui segnalati tre punti
che mi sembrano importanti nella percezione ecclesiale stessa – in prospettiva
ortodossa – del “mistero di comunione pneumatica” delle Chiese: a) il suo
contesto iconico-liturgico b) il suo fondamento escatologico-trinitario c) il
suo fulcro eucaristico-ecclesiale.
Il doppio movimento
“eucaristico” di ανάβασις (in salita, dal presente verso
il futuro ove ci aspetta il Padre) e di κατάβασις (in discesa, dal futuro da dove
sta il Padre, verso il presente) è veramente un viaggio di iniziazione
“pneumatica” alla vera vita (nello Spirito, in Cristo, con il Padre), al futuro
di ogni futuro, al futuro ultimo e definitivo della vera vita (sacramentum
futuri), con il quale l’iniziazione cristiana nel suo insieme trova la sua
perfezione (misterico-sacramentale). Il ritorno però dal futuro
ultimo e definitivo della vita (dal Suo regno-in patria) verso il presente
(verso la nostra storia-in via) fa parte integrante del viaggio
al futuro definitivo della storia e della vita, alla “vera storia” e alla “vera
vita” avvenire (del Cristo totale, escatologico e glorioso). Questa “vera vita”
e questa “vera storia” avvenire diventano il movente, il principio e il fine
della nostra missione nel mondo.
Questo è il motivo, mi sembra,
per il quale la Chiesa – il corpo di Cristo nel mistero del Regno di Dio e
Padre – non può che essere una realtà paradossale, cioè
“misterico-sacramentale”: una realtà stricto sensu “escatologica” che
peregrina paradossalmente nella “storia”, con una gamba lì (nella
meta-storia, quella del “Regno”) e l’altra gamba qui (nella storia, quella del
“mondo”) per così dire. Detto ciò, potrei benissimo capire una vostra eventuale
perplessità. Ma la “Chiesa” nel suo mistero mi sembra – anzi nel mistero del
Cristo totale, escatologico – prima di raggiungere la sua stabilità nel “Regno”
(in patria), potrebbe difficilmente evitare di zoppicare camminando
nella storia (in via). Perchè cammina per così dire con “disparità di
gambe” (una escatologica, l’altra storica).
Vogliate scusarmi per questa
parafrasi. Lo scopo era di farvi intravedere innanzitutto la visione ortodossa
(se non comune) della paradossalità intrinseca (sacramentale) della Chiesa
nella storia (in via), ma anche – e più profondamente – il fondamento
ultimo (e quindi primo in verità) della sua sacramentalità paradossale
nel Regno (in patria). Quello che è chiamato solitamente, presso gli uni
e presso gli altri “sacramento” – o meglio “mistero sacramentale” nel mio
linguaggio indica in prospettiva ortodossa una realtà paradossale nella
storia, il fondamento della quale sta nascosto con Cristo nel Regno
escatologico di Dio e Padre (da dove il Cristo regna). La Chiesa stessa, in
quanto corpo di Cristo in misterio (εν μυστηρίω), è tale e diventa tale di
“nuovo” ogni volta che partecipa in azione di grazie e sacramentalmente
alla vita misterica del Regno avenire (εν ευχαριστία).
Situati in questa prospettiva,
bisogna non perdere di vista che il termine “ortodosso” fa riferimento prima
di tutto - e in ultima analisi - alla “verità” permanente e
“cattolica” del mistero stesso di Cristo nel suo corpo ecclesiale
(eucaristico e dossologico), e non solo alla forma storica (culturale e
confessionale) del cristianesimo orientale bizantino-slavo. La connotazione del
termine “ortodossia” è strettamente ecclesiale, cioè “misterica” (in senso
paolino) e in ultima analisi “escatologica” (parusiaca); non semplicemente
“confessionale” (in senso confessionalista) o “storico-culturale” (in senso epocale).
Il suo contenuto coincide con quello del termine “cattolicità” in riferimento
al mistero di Cristo nel contesto globale (ανακεφαλαίωσις) e nella prospettiva
escatologica (βασιλεία του Θεού και Πατρός) dell’“economia paterna”.
Questa è una prospettiva
“ortodossa” la quale determina il mio contesto di comprensione – e quindi il
significato – dei termini “sacramentalità” e “amore”, “sponsalità” e
“eucaristia”. Che cos’altro potrebbe in fondo significare i termini
“ecclesiale” e “ortodossa” per una Chiesa di Chiese che noi crediamo
“cattolica” e “apostolica” in comunione di fede con la “Chiesa indivisa”?
Onestamente, credo che non possiamo né confondere ma neppure ridurre l’una a
l’altra, la “cattolicità ortodossa” e la “cattolicità romana”, nelle due Chiese
sorelle, ancora disgiunte.
4 - L’Alleanza sponsale nell’essere ecclesiale in
Cristo alla luce escatologica dell’Avvento
La celebrazione liturgica
dell’Avvento è per noi, prima della celebrazione della Natività del Signore, la
nostra “ora liturgica comune”. Il mistero stesso dell’Avvento – celebrato con
tanta gioia, specie in Occidente - proietta una nuova luce sul mistero salvifico
della Liturgia eucaristica nella storia, della Liturgia ecclesiale, nella sua
eucaristicità stessa, profetica per eccellenza: “essere ecclesiali come
eucaristia” significa anche “essere ecclesiali come profezia”: profezia di
Cristo che viene nel suo Regno, del Regno del Padre che ci aspetta sempre.
Profezia eucaristica e sacramentale” nelle nostre celebrazioni eucaristiche, in
Cristo e nello Spirito verso il Padre. Profezia di questo mistero dell’avvento
nella storia, in tutta la sua profondità escatologica: del “compimento
definitivo di ogni alleanza in Cristo, sigillata nel suo stesso corpo e
attraverso il suo stesso sangue di vita; “corpo di Cristo”, in senso personale
e escatologico, in senso eucaristico e ecclesiale, corpo di Cristo, risorto, asceso
e atteso: di Cristo che è venuto, che viene e che verrà nel suo corpo.
La categoria biblica di
“alleanza”, di promessa e di compimento (nella promessa) mi sembra essere in
rapporto stretto con la tematica della celebrazione sacramentale delle “nozze”
(matrimonio), soprattutto se vista alla luce dell’evento litugico dell’avvento
in prospettiva escatologica nel Regno (cfr. le “nozze dell’Agnello”). Avvento e
Pasqua, Pentecoste e Parusia (avvento nella novità escatologica alla luce della
Parusia): il mistero ecclesiale del tempo non è propriamente ciclico ma
tendente verso l’escaton (έσχατον), la Parusia e il Regno “a
venire” (e “avvenire”).
Questo periodo messianico ed
escatologico dell’avvento di Cristo e in Cristo, della nuova ed eterna alleanza
nel suo proprio corpo, mi sembra essere in rapporto stretto sia con la tematica
del mistero sponsale della Chiesa in Cristo visto a partire dal suo orizzonte
ultimo e apocalittico (le nozze dell’Agnello con la Chiesa) sia con la tematica
del mistero liturgico-eucaristico, del mistero sponsale per eccelenza
(bensì in modo prolettico, paradossale e profetico) della Chiesa in Cristo e di
Cristo nella Chiesa. Cioè dell’avvento del Regno di Dio nella storia del Re in
persona.
Questo “compimento” dell’alleanza
tra Dio e l’Umanità nel corpo di Cristo è veramente paradossale.
Al compimento definitivo
(pasquale) della nuova ed eterna alleanza nel suo corpo personale, - al
Risorto e asceso con il suo corpo storico, il Cristo Signore -
corrisponde strettamente la promessa decisiva del suo ultimo e glorioso avvento
e compimento, escatologico e cosmico. Il mistero profondo della sua Alleanza,
sarà manifestato a tutti e a tutto nella ricapitolazione gloriosa di tutti e di
tutto, nella pienezza eucaristica e nella gloria apocalittica, nello splendore
del suo corpo ecclesiale (Totus Christus, caput et corpus -
Agostino).
La profondità ultima di tal
compimento si manifesta nella glorificatio in eucharistia della
Chiesa nella storia, quella della salvezza, la quale continua in Lui e si
misura nella nostra attesa escatologica della sua Parusia, nell’attesa decisiva
(escatologica) del Risorto atteso. Questa alleanza in Cristo, pur essendo già
compiuta nella sua propria Alleanza nel suo stesso corpo (crociffisso, morto,
risorto, asceso e atteso nella gloria), nel suo stesso corpo eucaristico che è
la Chiesa “in misterio” (pasquale, pentecostale, escatologico) contiene in sé
il mistero propriamente “pneumatico” della “ricapitolazione escatologica”. E da
qui possiamo meglio intendere il grande mistero secondo Cristo e la Chiesa,
sposata in vista della ricapitolazione escatologica. Ma pure il vero senso del
matrimonio in Cristo tra uomo e dona, come “sacramento dell’amore”: di
pericoresi dell’uno nell’altro e in Cristo a immagine somigliante della
pericoresi ricapitolante, escatologica e apocalittica, secondo Cristo e la
Chiesa.
Questo - tra l’altro - mi sembra
essere il “grande mistero” della “ricapitolazione di tutto e di tutti”, del
mondo e della storia, nel Corpo del Cristo parusiaco, escatologico e
apocalittico.
La problematica sul sacramento
del matrimonio - o meglio sul mistero sacramentale delle “nozze” - ci
rinvia direttamente al “mistero nuziale” nella Chiesa. Riconosco volentieri che
questa tematica innanzitutto ecclesiologica, oltre che misteriologica (o
sacramentale, se preferite), coincide bene con il periodo liturgico dell’“avvento”
nel suo mistero escatologico. Nella nostra prospettiva il “sacramento
dell’amore” (G. Crisostomo) o “delle nozze” (matrimonio) rinvia al “mistero
dell’alleanza nel corpo di Cristo” (Eucaristia-Chiesa) e quest’ultimo al
mistero del “regno avvenire” (escatologia, la vera protologia). Per dirlo
parafrasando leggermente Massimo il Confessore: Dopo la caduta, badate bene,
non è dall’inizio (“prelapsario”) che la fine ultima si fa mostrare, ma
viceversa; è dalla fine ultima che l’inizio vero ci appare.
5 - Avvento, Ricapitolazione e Liturgia
eucaristica-sponsale
“Avvento” significa
innanzitutto “alleanza”, “promessa”, “compimento” e soprattutto “mistero”: il
mistero dell’economia di Dio secondo la sua ottica ultima e fondante (σκοπός); non secondo la nostra. Il contenuto del “mistero” è
“storico-salvifico” e la sua ottica è “escatologica”, non protologica (cioè non
secondo la nostra ottica storico-temporale). Ora in contesto liturgico
l’avvento, “anamnetico-e-epicletico”, è il periodo temporale più specifico in
cui la Chiesa, “facendo memoria” della “prima venuta nella carne” del
suo Signore, “attende con impazienza” la sua “ultima e gloriosa Parusia”
(presenza escatologica). Ed è quella che il libro dell’Apocalisse profetizza
riferendosi alla discesa della Gerusalemme celeste e alla celebrazione delle
nozze dell’Agnello –escatologiche – che celebriamo anticipatamente,
partecipando proletticamente, nella Divina Liturgia, al banchetto festivo nel
Regno. La Liturgia eucaristica costituisce il sacramento per eccellenza e il
fulcro di tutta la costellazione sacramentale nella Chiesa come sacramenti del
Regno.
L’“avvento liturgico” dunque, di
cui l’orientamento è escatologico nella storia (non meramente storico, o
“storiologico” per così dire, come uno potrebbe facilmente pensare) non
è affatto senza rapporto con il “mistero nuziale”, secondo il Cristo e la
Chiesa, escatologico, paradossalmente (cioè sacramentalmente) presente nella
storia, in maniera nascosta da decifrare. Tal “mistero nuziale” ha la sua
ultima verità e l’ultimo fondamento nelle stesse “nozze apocalittiche dell’agnello”,
quelle del “Regno venturo”.
Una interrogazione sul senso del
sacramento delle nozze celebrato in Ecclesia, non potrebbe che attirare
la nostra attenzione sulla stessa sacramentalità nuziale “nella Chiesa” (in
Ecclesia), “secondo Cristo” (in Cristo) nello Spirito Santo e
davanti al Padre (verso di Lui). Questo mi sembra essere il fulcro delle nostre
difficoltà, presso gli uni come presso gli altri, se non altro riguardo al tema
“matrimonio ed eucaristia” nel contesto delle interrogazioni sui matrimoni misti
tra cattolici e ortodossi.
Nella Lettera agli Efesini
l’amore espresso tra i coniugi è visto come un “grande mistero” e ciò in
proporzione al “mistero nuziale” d’amore “secondo Cristo e la Chiesa” tra
Cristo e la Chiesa. Si tratta qui di un’analogia di proporzionalità, come si
suol dire, non lo dobbiamo perdere di vista. È per questa ragione mi sembra che
Giovanni Crisostomo parla del “sacramento dell’amore” riferendosi ai
coniugi uniti personalmente “in Cristo” (nel loro battesimo) e anche tra di
loro (attraverso il loro matrimonio in Lui). Premetto che ogni volta che si fa
riferimento all’espressione “in Cristo”, la si debba intendere in modo
soteriologico trinitario. Come cioè “in Cristo e nello Spirito verso il Padre e
a partire dal Padre”. Detto ciò, il nostro battesimo “in Cristo” ci unisce a
lui personalmente in modo misterico-nuziale nel contesto comunionale più vasto,
quello della Chiesa, “in Cristo”.
* * *
Ogni prospettiva sacramentale
riguardo al matrimonio -nell’eucaristia e in eucaristia e come eucaristia - non
potrebbe fare l’economia di un interrogarsi più profondamente sul senso
misterico-sacramentale della sponsalità e dell’eucaristicità stessa “della
Chiesa” e “nella Chiesa” e “come Chiesa”: della Chiesa nel suo atto stesso
(liturgico-sacramentale) di “essere Chiesa”. Di essere cioè la “sposa vera e
unica di Cristo”, quella sposa che lui si è scelto come sposa[3] e che lui stesso predilige in modo unico in
mezzo a tutto il mondo (a fovore di tutto il mondo). La Chiesa è la Sposa per
eccellenza, sposata al suo unico Capo e Sposo in modo veramente mirabile:
essendo cioè chiamata, scelta da lui, è (unita) e viene (unita) e verrà
(unita) con lui e in lui “in eucaristia” (in eucharistia),
facendo con lui e in lui “un solo corpo” (sacramentale-eucaristico) e in “un
solo spirito” (pneumatico -escatologico).
Vi ringrazio dell’attenzione
paziente e vi auguro di tutto cuore “buon Natale”.
[1] Relazione al XVI Colloquio Cattolico-Ortodosso della
Facoltà Teologica Pugliese – Istituto ecumenico-patristico sul tema “I
matrimoni misti tra cattolici e ortodossi: Aspetti teologici, canonici e
pastorali” (Bari 17 dicembre 2010).
[2] Saranno forse dei modi ecclesiali nella storia intrinsecamente
divergenti o forse anche convergenti tra di loro? Convergenti o divergenti: da
“dove” (sito) e in che prospettiva (ottica)? Questo mi sembra essere il punto
fondamentale tra noi da approfondire in comune: il senso “ecclesiale” di
“cattolicità”, nella Chiesa (di Dio e Padre) e della
Chiesa (del Cristo Signore) e come Chiesa (nella “pienezza-e-presenza”,
escatologica, dello Spirito Santo). Non ci facciamo delle illusioni. Prova ne
sia, tra l’altro, la questione presente sul senso teologico e ecclesiale del
“matrimonio” nei “matrimoni”, specialmente quelli “misti”. Da questo punto di
vista; non soltanto da un punto di vista di “accomodamento pastorale”.
L’ultimo, non reggerebbe senza un approfondimento previo del fondo
teologico-liturgico, sottostante alle questioni pastorali. Lo sforzo adesso, è
di sollevare delle questioni remote, offrendo eventualmente, degli elementi di
riflessione ulteriore comune. Elementi che vanno ben al di là dei soli matrimoni
misti (e del solo periodo liturgico dell’Avvento) e che toccano quello che mi
sembra essere un aspetto decisivo del problema. Di un aspetto che divide le
stesse Chiese in se stesse in quanto Chiese, dividendo in seguito le famiglie
in quanto “miste”.
[3] O in una prospettiva francamente trinitaria del
mistero dell’elezione, si dovrebbe forse dire: “che gli è stata data come
Sposa (la Chiesa) dal Padre Suo e nello Spirito paterno”. Perchè qui la “Sposa”
è tutta l’umanità con la sua storia intera che il Figlio di Dio ha assunto in
sé incarnandosi dallo Spirito Santo nel grembo materno della Vergine Maria
facendosi “Figlio dell’uomo”, l’uomo per eccellenza, l’uomo nella sua piena
verità escatologica, l’ultimo Adamo. E ciò, senza minimamente cessare di essere
colui che era, che è e che sara: “il Figlio unigenito” del Padre, il Suo
“unico” in senso personale assoluto.